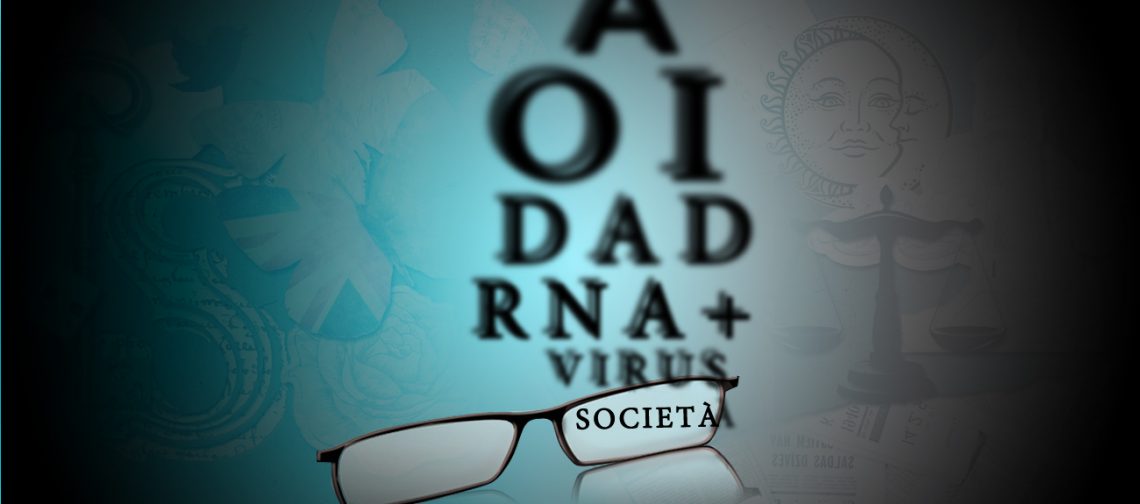È nei limiti del nostro linguaggio che accogliamo la realtà? O è piuttosto la nostra grammatica a dettar legge a ciò che quotidianamente viviamo? La complessità del linguaggio può complicare il mondo e, al contrario, la sua semplicità banalizzarlo, destrutturarlo, consegnarcelo in frammenti piccoli e comprensibili. Che lingua stiamo parlando, oggi, nella sospensione di un mondo stravolto da regole decise da un virus e dai suoi oppositori?
Arresto ogni domanda, e ragiono, poiché sento forte, nel nostro tempo, l’esigenza di comprendere.
Il linguaggio ha una naturale resistenza al cambiamento: nel momento in cui si modifica rispecchia non il medesimo minuscolo cambiamento nel tessuto sociale, ma una rivoluzione nello spirito dei tempi. Lo immagino come un enorme pachiderma che tende alla stasi, ma che poi si decide a spostarsi di un passo, sollecitato da mille interferenze d’insetto, quando proprio non può farne più a meno. È un bene che sia così, il linguaggio deve essere una struttura affidabile, come le fondamenta di una casa. Non può mutare ad ogni minimo cambiamento sociale.
La scelta dei termini che usiamo ci definisce. Nel momento in cui definiamo il mondo, noi definiamo noi stessi. Che ritratto delinea del nostro volto, in questo tempo di sospensione, ostilità reciproca e sopravvivenza, il nostro modo di esprimerci?
Termini scientifici sono ormai nella bocca di tutti: carica virale, mutazioni, anticorpi, sono solo alcuni esempi. Usarli ci dà l’illusione di padroneggiare la realtà che sta dietro, questa strana familiarità linguistica ci consegna uno scettro del potere non meritato, quello della conoscenza. Così questo linguaggio specialistico reso oggi accessibile dai media ci incoraggia ad entrare a passo spedito in un dibattito a cui non avremmo in fondo alcun diritto d’accesso. Lo stesso sta succedendo nel mondo della scuola: DAD, DDI, e altre pratiche d’uso diventano per mediazione delle televisioni e dei giornali patrimonio di tutti, e ognuno può definirne validità e modalità d’uso, così accade che impiegati alle poste, banchieri e shampiste si arroghino la presunzione di poter sentenziare su ciò che un dirigente scolastico dovrebbe decidere, e intanto si assiste tra ilarità e stupore, è fatto di cronaca, anche alla prescrizione della didattica a distanza da parte di un medico di base. Questo linguaggio in tempi emergenziali ha sfondato ogni muro di settore, ha aperto le porte della scuola al giudizio facile di chi non la vive quotidianamente, e quelle della sanità alla boria dell’uomo comune. Questo linguaggio livellante, in cui tutti possono dire tutto, sta scorrendo oltre i suoi argini, e modificando la visione collettiva dei fatti. Quando torneremo a ristabilire i paletti, onorare le buone forme, riconoscere la nostra assoluta mancanza di strumenti nei settori di competenza altrui? Quando torneremo a dirlo con parole nostre?
Copyright ©️ 2020-2030, “Spazi Esclusi” – Tutti i diritti riservati.

Mi chiamo Irene e sono il direttore di questo magazine on line, fondato con l’Associazione Culturale “Le Ciliegie”. Nel lontano 2003 mi sono laureata in Filosofia con 110 su 110 e lode, tesi in Bioetica sull’esistenzialismo francese, e proprio come Jean Paul Sartre, mio filosofo del cuore, ho idea che “terminerò la mia vita esattamente come l’ho iniziata: tra i libri”. Sono una giornalista culturale e una docente di Filosofia e Storia: il giornalismo è la mia scusa per scrivere, l’insegnamento la mia palestra. Ma la verità, dietro tutte queste maschere di carne, è che sono una scrittrice, e scorre inchiostro nelle mie vene.